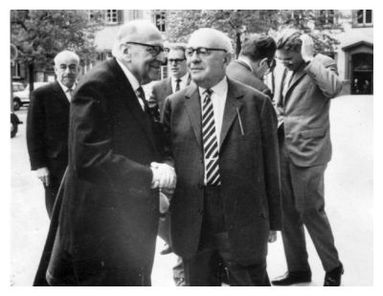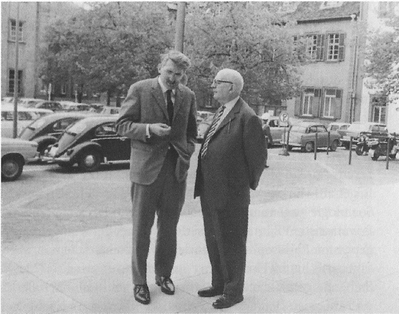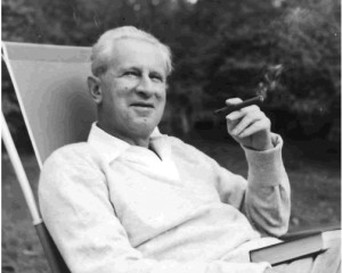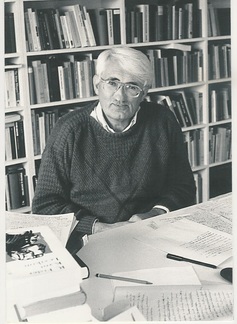Teoria Critica |
Il pensiero viene sottoposto alla sottile censura del terminus ad quem: nella misura in cui assume una forma critica, esso deve saper indicare che cosa vuole di positivo. Se trova che questa positività è inaccessibile, viene accusato di rassegnazione, di stanchezza, come se l'inaccessibilità fosse una sua colpa, e non la segnatura della cosa. |